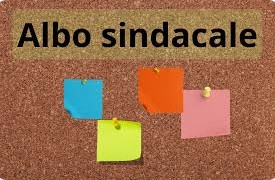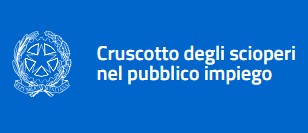Presentazione
L’IC di Guido Monaco, in collaborazione con i Comuni di Castel Focognano, Chiusi della Verna, Chitignano e Talla, intende proporre, all’interno dell’offerta formativa un percorso pluridisciplinare per la scuola secondaria di 1° grado, dedicato al tema della Festa della Toscana 2024,: TOSCANA: terra di genio e di innovazione”
Titolo dell’itinerario di riflessione: “Immaginare un nuovo possibile … per cambiare un paradigma ”
4.1. Immaginare il possibile per cambiare un paradigma
La Toscana, fin dall’abolizione della pena di morte ai tempi del Granducato, ha precorso i tempi ed è stata terra di scelte geniali e innovative. Con il percorso di riflessione che vogliamo proporre agli studenti della scuola secondaria dell’Istituto intendiamo porre l’accento su alcuni dei tanti intellettuali toscani che con le loro opere e con le loro intuizioni geniali hanno rotto uno schema consolidato a livello culturale e hanno fatto intravedere un nuovo paradigma con il quale vedere il mondo e sul quale l’umanità ha fatto progressi in avanti. È importante far cogliere alle nuove generazioni quanto l’opera di alcuni intellettuali ha determinato un cambio di prospettiva, generando risvolti enormi, a livello culturale, di cui noi stessi oggi ne godiamo. Ogni autore sarà approfondito con lo studio di brani o con uscite nel territorio per privilegiare un approccio esperienziale motivante e consentirà nei vari percorsi formativi proposti di soffermarsi anche su quanto incida in termini orientanti.
4.1.a. Dante, l’uomo che ha fondato la lingua italiana
Il ruolo di Dante nella storia della lingua italiana è stato fondamentale. In particolare in una sua opera il De Vulgari Eloquentia dedica uno studio accurato alla lingua volgare, che viene definita dall'autore: cardinale, perché deve essere comune tra tutti gli abitanti della penisola , aulica, perché sia parlata anche nella corti più nobili e curiale, perché le sue regole devono essere fissate dalla "curia", cioè l'insieme dei saggi e dei sapienti d'Italia. In questo modo a suo modo intraprende quella. La splendida metafora che Dante utilizza nel XVI capitolo del I libro per questa ricerca del volgare illustre e perfetto, che poi inevitabilmente verrà scelto nel volgare della sua città (Firenze), è quella della caccia a una pantera, una pantera “redolentem ubique et nec apparentem”, cioè il cui profumo si fa sentire ovunque, ma che non si trova in nessun luogo”. Dante in un primo momento aveva visto il volgare solo come lingua che seguita l’uso e continuamente variava, poi ne indaga la natura e la grammatica l'artificio e la convenzione, infine ne vede la ragione e ne afferma “la naturale necessità". Si tratta di un cambio di paradigma che apre le strade all’affermarsi della lingua italiana.
4.1.b. Brunelleschi, l’uomo che inventò la prospettiva
Giotto e Ambrogio Lorenzetti nel XIV secolo iniziano ad organizzare in modo accettabile lo spazio pittorico al fine di renderlo più verosimile. Tuttavia si sente la necessità di trovare un sistema scientificamente rigoroso per rappresentare lo spazio. Con Filippo Brunelleschi (1377 - 1446 ) si ha la prima definizione della nuova scienza della rappresentazione: la prospettiva. La paternità di questa invenzione è suffragata da testimonianze di contemporanei, primo fra tutti Leon Battista Alberti, che scrivendo nel 1436 il Trattato De Pictura in lingua volgare dedica l’opera a «Pippo architetto» auspicando che egli, grazie al suo «ingegno maraviglioso», potesse correggere eventuali errori o debolezze nelle dimostrazioni della sua opera.
La padronanza di procedimenti matematici, geometrici e ottici di Brunelleschi produsse un primo clamoroso risultato verso il 1413, con la tavoletta prospettica che rappresentava il Battistero di S. Giovanni a Firenze e successivamente una seconda tavoletta realizzata in Piazza della Signoria, con la vista di Palazzo Vecchio e della Loggia dei Lanzi. La cronaca (1475 ) di Antonio Manetti, biografo di Brunelleschi, descrive l’esperimento e Giorgio Vasari nelle sue Vite (circa 1550) riferisce che egli «trovò un modo per costruirla correttamente, che fu di disegnarla per mezzo della pianta e del prospetto e per via della intersecazione». Dallo studio delle varie fonti, gli studiosi hanno formulato ipotesi, a volte contraddittorie, ma tutte concordano sul riconoscimento che questi due esperimenti di Brunelleschi hanno fondato la prospettiva lineare (o prospettiva artificiale ) secondo costruzioni scientifiche, forse già note, ma di cui egli fece una mirabile sintesi. Si tratta di un cambio di paradigma che rivoluziona la rappresentazione dello spazio nella pittura.
4.1.c. Galilei, l’uomo che cambiò lo sguardo con cui guardare il cielo
Galilei è lo scienziato che ha contributo maggiormente a fondare il metodo scientifico odierno: G. era convinto che la Natura fosse governata da leggi che mettevano in relazione elementi della natura stessa secondo rapporti di tipo matematico, per conoscere la Natura occorreva ricercare queste costanti e utilizzare un linguaggio matematico. G. con un'invenzione proveniente dall'Olanda - il cannocchiale – indaga le stelle, aprendo così la strada ad un nuovo corso di scoperte astronomiche che avrebbero colto le analogie tra corpi terrestri e celesti.
Un cambio di paradigma che porta ad approdare definitivamente e strutturalmente al metodo ipotetico -deduttivo scientifico.
Nel laboratorio “Nati sotto una buona stella” si svolgeranno approfondimenti sul sistema solare e l’Universo. Interverranno come esperti formatori dell’INAF Osservatorio di Arcetri.
4.1.d. Guido d’Arezzo, l’uomo che inventò la notazione musicale moderna
Sebbene i natali siano incerti e vengono contesi, Arezzo rimane la terra che accoglie il genio di Guido Monaco, meglio conosciuto appunto come Guido d’Arezzo, codificatore della notazione musicale moderna. Ad Arezzo scrive il suo elaborato più famoso, il Micrologus, un testo fondamentale diventato il trattato di musica più letto del medioevo. Da insegnante di musica, Guido si accorse delle difficoltà dei suoi confratelli nel memorizzare i canti della tradizione gregoriana e la ritmica. Allora codifica il modo di scrivere le note definendo le posizioni di esse sulle righe e negli spazi del rigo musicale: basandosi sull'esperienza del cantore Guido sottrae la trasmissione della musica dal dominio esclusivo dell'oralità, con l'invenzione della solmisazione e il perfezionamento della notazione su rigo. Per aiutare gli altri monaci a ricordare le note, Guido D’Arezzo usa le sillabe iniziali dei versi dell’inno a San Giovanni Battista. Si tratta di un cambio di paradigma che porta la trasmissione della musica da un uso esclusivo orale a quello scritto